Rapporto di Larissa Wilwert sulla sua permanenza presso la Fondazione di Studi Storici “Filippo Turati” (Firenze) .

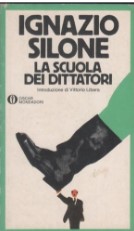
Dal 31 marzo al 5 aprile 2025 sono andata a Firenze, dove ho potuto - grazie a una borsa individuale della Fondazione Heimann - consultare il lascito dello scrittore, saggista e politico Ignazio Silone (pseudonimo di Secondino Tranquilli). Nel contesto del mio progetto di dottorato comparativo, in cui sto indagando la particolare forma del dialogo letterario autonomo tra il 1890 e il 1950, Silone rappresenta in un certo senso la figura intermedia tra i (con)testi italiani, tedeschi e francesi: Come emigrato politico italiano, nel 1938 pubblicò a Zurigo la sua raccolta di dialoghi Die Schule der Diktatoren originariamente scritta in italiano e poi tradotta in tedesco, che fu contemporaneamente pubblicata in traduzione inglese come The School of Dictators sia da Harpers and Brothers a New York che dall’editore londinese Jonathan Cape. Una versione spagnolo-argentina La escuela de los dictadores fu aggiunta nel 1939, mentre la traduzione francese fu rimandata a dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Fu solo negli anni Sessanta che la Scuola dei dittatori. divenne anche accessibile – in forma riveduta – a un vasto pubblico italiano.
Larissa Wilwert
Esaminando la corrispondenza degli anni 30 alla Fondazione di Studi Storici „Filippo Turati“ mi ha colpita la naturalezza linguistica con cui Silone ha cercato di affermarsi in un contesto internazionale, mantenendo la sua corrispondenza non solo in italiano e tedesco, ma anche in francese, inglese e spagnolo. Il mio particolare interesse si è ovviamente rivolto ai commenti sulla sua raccolta di dialoghi, che ho individuato non solo nelle numerose censioni della stampa inglese-americana, tedesca e francese, ma anche nell’intensa corrispondenza con Bernard von Brentano, Siegfried Kracauer, Elisabeth (“Medi”) Mann e il successivo marito di quest’ultima, Giuseppe Antonio Borgese. Sembra che i diversi lettori abbiano avuto difficoltà a sopportare la tensione tra la rappresentazione satirica dell’umanità e l’istruzione pedagogica, che è però il punto forte della Scuola dei dittatori. Allo stesso tempo, numerosi recensori hanno criticato la forma ibrida del dialogo, censurando in particolare il fatto “dass da die Tradition gebrochen ist” (Fritz Brupbacher). I risultati del soggiorno di ricerca rappresentano per me il punto di partenza per indagare ancora più intensamente il significato del dialogo letterario all’interno dell’esilio europeo tra il 1930 e il 1950 e per prendere in considerazione un possibile cambiamento di genere, motivato proprio dall’esperienza dell’esilio.
Ringrazio vivamente la Fondazione Heimann per il suo gentile sopporto del mio soggiorno di ricerca e la Fondazione di Studi Storici “Filippo Turati” per la perfetta organizzazione e la messa a disposizione dei materiali d’archivio.